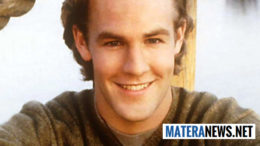Il carrello della spesa degli italiani è diventato il simbolo di una contraddizione economica che pesa direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie, che spendono sempre di più, ma si portano a casa meno.
I dati diffusi dall’Istat e analizzati da Assoutenti fotografano una realtà preoccupante.
Nei primi sette mesi del 2025, le vendite di beni alimentari sono diminuite in volume dello 0,8%, mentre in valore sono cresciute del 2,1%.
Tradotto: i consumatori hanno speso 1,3 miliardi di euro in più, pur acquistando meno cibi e bevande.
Un paradosso che rivela con chiarezza, secindo quifiannza, come l’inflazione alimentare stia erodendo il potere d’acquisto, modificando abitudini di spesa e di consumo, aggravando le disuguaglianze tra famiglie.
Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, le cause principali vanno ricercate nella crisi delle materie prime e nel conseguente aumento dei costi lungo tutta la filiera.
Cereali, oli vegetali, zucchero e prodotti lattiero-caseari hanno registrato rincari significativi già nel 2024 e la dinamica non sembra essersi arrestata nel 2025.
Le tensioni internazionali, le difficoltà logistiche e le ripercussioni del cambiamento climatico hanno reso più costosi i processi di produzione, trasformazione e distribuzione.
Il risultato è un carrello della spesa sempre più caro, con inflazione a due cifre per alcuni beni di largo consumo.
Pasta, pane, latte e carne – i pilastri della dieta quotidiana – sono diventati più onerosi, costringendo le famiglie a fare scelte difficili: ridurre la quantità acquistata, sostituire prodotti di marca con quelli senza marchio, rinunciare ad alcuni alimenti ritenuti non essenziali.
Non tutte le famiglie vivono allo stesso modo questa nuova stretta. Quelle a reddito basso o medio-basso sono le più penalizzate.
Per loro infatti la spesa alimentare rappresenta una quota molto più alta del bilancio mensile. In questi nuclei, ogni aumento dei prezzi si traduce immediatamente in sacrifici tangibili.
Ma anche le famiglie del ceto medio non sono indenni. Il rischio, se questa tendenza proseguirà, è duplice:
- l’aumento della malnutrizione qualitativa – con un ricorso crescente a cibi meno salutari ma più accessibili;
- l’indebolimento di interi settori produttivi, incapaci di reggere a lungo un mercato in contrazione.
Il meccanismo che porta a spendere di più per comprare meno non dipende solo dall’aumento dei costi di produzione. C’è anche la dinamica della distribuzione e della formazione dei prezzi al dettaglio.
La grande distribuzione organizzata, pur cercando di calmierare i prezzi con promozioni e sconti, non riesce a compensare del tutto i rincari provenienti dall’origine.
Le piccole botteghe, dal canto loro, soffrono ancora di più perché hanno meno margini di negoziazione con i fornitori.
Così, l’inflazione alimentare diventa una realtà generalizzata, che non lascia spazi di fuga ai consumatori.
Infatti, secondo le stime Istat, ad agosto 2025 conferma una decelerazione del tasso d’inflazione, ma non uno stop.
E poiché l’inflazione non rappresenta i prezzi in sé, ma la velocità di aumento degli stessi, se diminuisce ma rimane positiva, i prezzi del paniere alimentare continuano ad aumentare, ma semplicemente a un ritmo più lento. Perché i prezzi scendano davvero, l’inflazione dovrebbe diventare negativa.